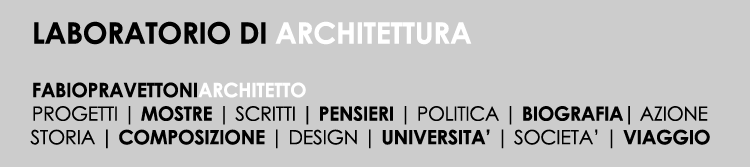In un estate che ormai scivola via tra un presidente che va a troie e troie che vanno in cerca del loro presidente, ecco che un gruppo di varesotti che si spaccia portavoce di un popolo, quelli che a Roma chiamano i
Lumbard, che di
Lumbard o che di
heimat lumbard ormai hanno ben poco, ti tirano fuori l’annosa, direi ormai secolare, questione della bandiera italiana e delle bandiere nazionali.
Premesso che non amo particolarmente la nostra bandiera nazionale, devo riconoscere che se letta in amicale contrapposizione con il tricolore transalpino, se letta cioè con un occhio di riguardo a quel gemellaggio franco italiano ora dimenticato, o per sempre cancellato, a causa di un campo verde segnato di bianco, lungo circa 100 metri, e di ventidue uomini che giocano al
forbal, allora quel simbolo trova di colpo una grande forza. Il Tricolore italiano è oggi infatti simbolo di libertà e ha alle sue spalle una lunga storia fatta di lotte, di grandi uomini e purtroppo di grandi assassini che hanno ucciso migliaia, milioni, di giovani mandati allo sbaraglio nelle guerre più assurde.
Il 15 maggio 1796 «il generale Bonaparte entrò in Milano, a capo di quella giovane armata che aveva varcato allora il ponte di Lodi e appreso al mondo che dopo tanti secoli Cesare e Alessandro avevano un successore. I prodigi di ardimento e di genio a cui l’Italia assistette nel giro di qualche mese ridestarono un popolo addormentato», così inizia la Certosa di Parma di Stendhal
[1]. «Ma per chi, quel mattino del maggio 1796, si trovò sul corso di Porta Romana a veder entrare in città quell’accozzaglia di briganti condotta alla vittoria da un pallido generale ventisettenne, quell’ingresso non rimase uno dei soliti spettacoli a cui la folla era chiamata, di tanto in tanto, a fungere da contorno, pronta a scomparire subito dopo, nella laboriosa ubbedienza, come tutti gli altri elementi di una coreografia posticcia: fu la ventata dell’eccezione, l’improvviso balenare di un’avventura da vivere come un altro destino»
[2]. Quello fu l’inizio del tricolore, del tricolore e della sua storia di rivoluzione. La rivoluzione borghese dei giovani parigini entrati a Milano, le assurde lotte indipendentistiche, savoiarde, le vite di milioni di giovani mandati al macello nelle guerre mondiali, la Resistenza, tutte storie di lotta, di passione e di rivoluzione, tutte storie accumunate da quel vecchio tricolore franco-italico. Solo se letto in questa chiave il tricolore adottato dalla Repubblica Cisalpina, quando l’Italia ancora non esisteva e la Lombardia di oggi neppure, ha un grandissimo valore, rivoluzionario e progressista.
Premesso questo, è di questi giorni la notizia che i moderni
Lumbard seguaci
del Bossi vogliono equiparare, mi pare di avere capito così, il tricolore alle moderne bandiere regionali. «Ma davvero i cuori degli italiani vibrano così tanto al garrire dei vessilli regionali da giustificare la loro promozione nella Carta?»
[3]. Tranne la bandiera del Veneto, copia mal riuscita del nobile simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia, o tranne quella di stampo savoiardo del Piemonte, o ancora quella della Sardegna, che cosa proviamo di fronte a quelle bandiere? Cosa prova un marchigiano di fronte quella M e quel picchio stilizzati, frettolosamente adottati nel 1995, o cosa prova un laziale di fronte quell’intricato groviglio di simboli, o ancora un emiliano e un romagnolo – che già sono stati forzatamente messi insieme dalla legge moderna – cosa provano di fronte quella brutta bandiera? E infine cosa prova un milanese di fronte alla rosa camuna?
Certamente quello del regionalismo, o delle lingue preunitarie, nazionali, o dell’unità dello stato italiano, sono temi difficili che non si possono banalizzare o semplificare, o peggio ridicolizzare, come sempre si è tentato di fare. Tomasi di Lampedusa, Isella, Trilussa, sono oggi dimenticati e le lingue nazionali sono state banalizzate e declassate dal fascismo alla stregua di dialetti. Ma torniamo alla bandiera. Prendiamo ad esempio la moderna Lombardia. Essa è il risultato almeno dell’unione di uno stato, quello Milanese, e di una parte di stato, quello veneziano. Il confine è da sempre, o quasi sempre, l’Adda. Milano ha da secoli due bandiere. Una di lotta e una di rappresentanza: quella di lotta, la croce di San Giorgio, condivisa con altre città cattoliche, penso a Barcellona, Genova, ecc, è oggi divenuta il simbolo di una squadra di calcio, la F.C. Internazionale; quella di rappresentanza, il Ducale con il suo biscione azzurro e l’aquila imperiale su fondo giallo – a ricordare il legame non con Roma e il papa ma con il Sacro e Romano Imperatore germanico – vengono venduti tra una salamella e un fazzoletto verde alle feste padane della Lega Nord, ma sarebbe meglio chiamarle feste prealpine, perché della cultura fluviale padana hanno ben poco.
Perché in questo stato senza memoria troppo preso da altre vicende, spesso a sfondo erotico, il Ducale, l’antica, unica e ultima bandiera dello Stato di Milano è declassato a oggetto di culto per giovani militanti e la rosa camuna, che credo sia una stilizzazione di un’incisione rupestre della Val Camonica (Brescia), di recente già territorio della Repubblica Serenissima, è invece innalzata a simbolo regionale, ora anche nazionale?
(continua)
[1] Stendhal (pseudonimo di Henri-Marie Beyle) fu scrittore francese nato a Grenoble, il 23 gennaio 1783 e morto a Parigi, 23 marzo 1842. Tra le sue opere è certamente da ricordare Roma, Napoli e Firenze, (titolo originario Rome, Naples et Florence), un diario di viaggio scritto durante il periodo di congedo che ebbe in Italia alla caduta dell'imperatore (era ufficiale di cavalleria prussiano a Berlino). Stendhal soggiornò a Milano per sette anni e la descrisse in quel libro in modo sapiente, al pari, forse meglio, di Manzoni.
[2] DANTE ISELLA, Milano Capitale nelle vedute di G. Gallinari, in idem, I lombardi in rivolta. Da Carlo Maria Maggi, a Carlo Emilio Gadda, Einaudi, Torino, 1984, p. 107.
[3] ALESSANDRO LONGO, Tra Petaso e rosa camusa quell’Italia dei campanili a caccia di simboli e jingle, in La Repubblica, 6 agosto 2009, p. 3.